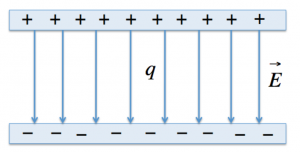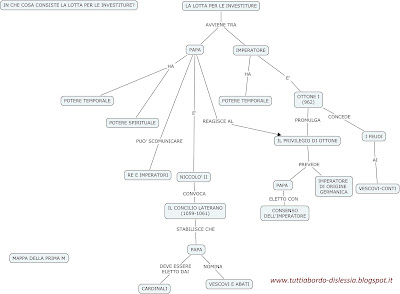[Ripubblichiamo questo articolo uscito su minima&moralia il 19 aprile 2015]
di Valerio Valentini
«Ma devi per forza chiamarlo ultimo? Non ce la fai proprio a dire quinto? Non senti come suona già molto meno angosciante?».
Seduto al tavolino del bar, subisco in silenzio il rimprovero della mia compagna di università. La discussione, rimasta amabile finché si è mantenuta sul vago («Ma perché ti ostini a prendere il caffè senza zucchero?», «Devi assolutamente vedere l’ultimo video dei The Jackal con Malika Ayane»), s’è avariata d’improvviso, non appena ci siamo ritrovati a contare gli esami rimasti prima della tesi. Quando poi, incautamente, le ho chiesto se avesse deciso cosa fare, alla fine dell’ultimo anno, lei ha tirato indietro la testa, stizzita, s’è calata gli occhiali da sole sul viso. Ed è sbottata.
«Piuttosto, che programmi hai per stasera?»
«Pensavo di andare a cinema, a vedere Fino a qui tutto bene»
«Ecco, tanto per non sciropparsi un altro po’ d’angoscia …»
«È una commedia»
«Sì, ma è una commedia sull’angoscia post-laurea. No grazie»
È un peccato che non sia voluta venire a cinema: sono convinto che Fino a qui tutto bene le sarebbe piaciuto. E non perché, in effetti, non fosse un film sull’angoscia post-laurea. L’angoscia c’è, è il basso continuo cha accompagna il racconto degli ultimi, folli giorni di vita universitaria dei cinque protagonisti; eppure, paradossalmente, quell’angoscia resta sul fondo della vicenda, presenza costante ma ignorata, e le poche volte in cui prorompe in primo piano, viene puntualmente aggirata.
Lo ha spiegato, in fondo, anche il regista del film, Roan Johnson, raccontando la genesi dell’opera. Un paio d’anni fa, l’Università di Pisa commissiona a Johnson e alla sua compagna, Ottavia Madeddu, un documentario sull’ateneo: e i due autori, intervistando gli studenti, restano piacevolmente sorpresi dalla loro voglia di riscatto. C’è la crisi, c’è la consapevolezza che trovare un lavoro dopo la laurea, o dopo il dottorato, sarà difficilissimo, ma non per questo si deve rinunciare, affermano gli intervistati, a coltivare le proprie passioni, a nutrire aspirazioni ambiziose. L’uva migliore si intitolava quel documentario, perché, come uno studente di agraria raccontò davanti alla macchina da presa, il vino più pregiato proviene molto spesso proprio dai vigneti che hanno avuto dei problemi, che hanno sofferto. È lì che nasce l’idea di realizzare Fino a qui tutto bene: che è un racconto sul trauma della fine di quel periodo sospeso durante il quale si è studenti universitari, ma è anche la testimonianza, e per certi versi la celebrazione, del coraggio e della perseveranza di tanti giovani laureandi italiani.
E proprio in questo, nell’osmosi tra l’inquietudine e la speranza, tra l’ebbrezza di un presente prolungato fino all’inverosimile, e l’ansia di doversene staccare, che il film trova il suo equilibrio. I dialoghi sono ben scritti e, nonostante i protagonisti parlino tutti tantissimo, mai pesanti; tra i cinque coinquilini, costretti da Johnson a vivere insieme 24 ore su 24 durante le riprese, l’affiatamento è assoluto, e la loro recitazione è, nel complesso, molto buona; azzeccate le musiche, così come la scenografia casalinga; le suggestive panoramiche sul Lungarno e sui tetti di Pisa riescono persino a non sembrare delle cartoline scontate. Ci sono delle scene, poi, davvero bellissime. Il viaggio in macchina sulle note di Morirò d’incidente stradale dei Gatti Mezzi, mentre fuori dal finestrino scorrono, per l’ultima volta, ombre e colori di un panorama divenuto quotidiano, è un’efficace rappresentazione di ciò che è il distacco, l’abbandono di una condizione esistenziale vissuta per qualche stagione come se dovesse essere per sempre.
La telefonata via Skype in cui Ilaria (Silvia D’Amico) confessa ai suoi genitori di essere incinta fotografa con sottigliezza non comune il corto circuito avvenuto tra due culture che sembrano appartenere a ere geologiche diverse, e che invece sono separate da neppure quarant’anni: quella di semplici, piccolissimi imprenditori di provincia, con un italiano stentato e un attaccamento morboso al lavoro e alla famiglia, e quella di una ragazza scapestrata, appassionata di politiche di rimboschimento, che gode nel mostrare una disinibizione sessuale nella quale, in realtà, finisce per annegare. Tutto ciò rende il film estremamente piacevole. Ma, in alcuni suoi aspetti, anche ambiguo.
Verso la metà del film, Cioni (Paolo Cioni), Vincenzo (Alessio Vassallo) e Andrea (Guglielmo Favilla), attraversano mezza Pisa trasportando uno specchio: uno specchio che un loro amico ha deciso di ricomprarsi per 200 euro, e nel quale loro, camminando, non si guardano mai, finché non si siedono per terra, esausti, nell’attesa dell’acquirente che tarda a farsi vivo: solo a quel punto si fermano ad osservare la propria immagine. «Ma sta minchia di torre – domanda Vincenzo durante il tragitto – perché è storta?». E qui parte la spiegazione di Andrea, che offre, forse, la chiave di lettura dell’intero film. «Il punto non è ragionare su perché la torre di Pisa penda adesso, il punto è ragionare su quando si è storta: mentre la costruivano. Nel millecentoequalcosa avevano costruito i primi due cerchi, ma c’è stato un cedimento perché sotto è paludoso: e invece di dire “fermi, s’è fatta ‘na cazzata, non si può innalzare un campanile a Dio storto, che figura si fa …” hanno deciso di perserverà nella cazzata: uno bravo si fermerebbe, un mediocre pure, ma il folle no, va dritto nello sbaglio, persevera nello sbaglio, così tanto che poi arriva al pezzo inimitabile, al genio».
Il film mette immediatamente in guardia dai rischi di questa retorica un po’ renziana della Genialità («Meucci? A genius»): davanti ai tre studenti, nel riflesso dello specchio appare, in sella a una bicicletta, uno strano individuo, con un costume talmente improbabile che nemmeno il Renato Zero dei tempi migliori. Eppure, è proprio attraverso il ricorso a questa retorica – all’idea, cioè, che perseverando nella cazzata si riesca spesso a raggiungere una qualche realizzazione personale – che il film sembra voler risolvere lo scacco esistenziale in cui i protagonisti si ritrovano impantanati alla fine della loro carriera universitaria.
Sembra volere, ho detto, perché in effetti – com’è giusto e naturale che sia – non ci riesce (e questo, temo, sarebbe piaciuto meno alla mia amica angosciata). Dei cinque coinquilini, nessuno ottiene davvero quello che voleva. Vincenzo, che forse è quello messo meno peggio di tutti, trova inaspettatamente nell’Islanda il suo unico, non esaltante ma lo stesso benedetto, futuro di professore di vulcanologia. Francesca fa di tutto per non ammettere l’inconsistenza delle sue velleità d’attrice: ma in realtà, che a Milano possa trovare «un agente» grazie ai suoi «contatti», non ci crede troppo neppure lei. Andrea resta sospeso tra l’idea di scappare in Nepal, per aiutare un amico nella gestione di una fattoria, e quella di tornare farsi umiliare dalla sua ragazza, Marta (Isabella Ragonese), attrice emergente che ha da poco conosciuto il successo, grazie a una fiction di quart’ordine: anche Andrea ha coltivato il sogno di una carriera nel mondo del teatro, ma è rimasto annichilito dall’idea che l’unico ruolo che potesse davvero interpretare fosse quello del «fidanzato di una che ce l’ha fatta». Ilaria si rassegna a dover tornare dai suoi e allevare un bambino non esattamente desiderato, a meno che, alla fine, non si lasci convincere dal Cioni. Cioni, appunto, il più intimamente legato al gruppo, quello che sembra soffrire, nonostante la sua apparente leggerezza, il distacco nel modo peggiore: attratto da Ilaria (lo si percepisce fin da quanto, con estrema dolcezza, quasi facendolo sembrare un gesto normale, cerca di proteggerla dal fumo della sigaretta di Francesca) e dai suoi capricci, la inviterà a trasferirsi nel rustico della sua casa di Pisa, e crescere lì il bambino che aspetta. E poi c’è – c’era – il sesto coinquilino, la cui assenza pesa in maniera tragica sulla convivenza degli altri cinque: si è suicidato pochi mesi prima di terminare gli studi, simulando un incidente stradale.
Insomma, un naufragio esistenziale collettivo (con la parziale eccezione, come s’è detto, di Vincenzo), reso meno angoscioso, nella narrazione di Johnson, da un lato dall’amicizia che lega i cinque coinquilini, e dall’altro dalla consapevolezza che gli Indimenticabili Anni Dell’Università sono stati un periodo di vita esaltante.
Ma – ed è questa la domanda che il film spinge a porsi – quanto possono valere, davvero, queste consolazioni? È proprio andato tutto bene, fino a qui? Certo, il divertimento, le sbornie, le feste, il sesso, e anche le assurde, stupende abitudini della vita da universitari fuori sede: la «pasta col nulla», le muffe nel frigo, le liti per il bagno condiviso, per i letti condivisi, per gli amori condivisi. Certo. Ma poi? Chi se ne frega del poi, si dirà, intanto godiamoci questo momento. E però l’idea che cinque o dieci anni della propria vita possano essere meravigliosi soltanto se considerati come un periodo da isolare da tutto il resto e mettere in una teca di vetro, be’, è davvero deprimente.
E in fondo un po’ deprimente, almeno a me, è apparsa anche la prospettiva di vita dei cinque coinquilini: i quali accettano, in definitiva, di arrangiarsi. Decisione anche nobile, senza dubbio, ma spesso tragicamente prossima a quella, assai meno nobile, dell’arrendersi. Nel momento in cui le speranze adolescenziali smobilitano di fronte alla scadenza di quella sorta di esenzione dalla realtà che sono gli anni universitari (le scenografie e i costumi della compagnia teatrale “I poveri illusi” finiranno accatastati in un garage), ecco che quelle stesse speranze si rivelano per quello che sono sempre state: nient’altro che aspirazioni sgangherate, arrangiate più con euforia che non con effettiva coscienza. Nulla di male in questo, ovviamente, se non fosse che proprio in quegli abbozzi di progetti si arriva spesso a riporre l’intera aspettativa di una realizzazione personale.
Da una parte, dunque, le assurde logiche dell’università, che intrappolano gli studenti in un gioco a volte esaltante a volte avvilente, ma quasi sempre allucinogeno («Si passavano gli esami, ogni esame che si passava “tutto bene”, la festicciola, cin cin … ma fuori di qui è una tragedia», realizza Vincenzo, il più lucido dei cinque). Dall’altra parte, i vaghi sogni di un’alternativa: sogni frustrati dalla stessa routine universitaria, nell’attesa dell’illuminazione geniale o, più semplicemente, di un provino o una scritturazione. Nel mezzo, parecchi anni della propri vita passati a fare cose che in realtà – ebbrezze varie a parte – non sono le cose che si sarebbe realmente voluto fare.
L’università è senz’altro un periodo straordinario di formazione e di crescita, sia che poi si diventi un luminare di astrofisica o un critico letterario, sia che si decida di fare l’idraulico o il contadino. Ed è anche un modo per aumentare la cultura generale di un Paese, innalzare il livello del dibattito politico, eccetera. Tutto questo, in teoria. In pratica, bisognerebbe forse chiedersi se davvero l’università debba continuare ad esser considerata come l’inevitabile, obbligata scelta di chiunque voglia approfondire certe sue conoscenze, nell’attesa di capire cosa fare nella vita. L’opinione diffusa è quella secondo cui l’università sia un momento di riflessione e di orientamento, in cui trovare la propria strada; eppure a volte è proprio l’università, questo tempio intoccabile delle magnifiche sorti e progressive, che finisce col depistare, col disorientare, persino con l’inaridire.
Dei cinque protagonisti del film, ad esempio, a me sembra che l’unico per cui frequentare l’università abbia avuto un senso sia proprio Vincenzo. E non perché, banalmente, è l’unico che trova il modo di proseguire con successo la sua carriera accademica: ma perché, invece, è l’unico che desiderava fare ciò per cui ha studiato, l’unico che ha investito tutto in quella sua scelta, l’unico che – e non a caso questo gli verrà rimproverato, quasi fosse una colpa, dai suoi coinquilini – ha accettato fino in fondo i sacrifici e le rinunce che una seria esperienza universitaria impone. Andrea, Francesca, il Cioni e Ilaria avrebbero fatto meglio, mi pare, a fare altro: magari proprio una scuola di recitazione (come effettivamente hanno fatto, tra l’altro, e senza prima sentirsi in dovere di prendersi una laurea, gli stessi attori protagonisti del film). Questo non li avrebbe in alcun modo resi persone inferiori rispetto a Vincenzo: soltanto, persone interessate ad altro più che alla ricerca e allo studio tradizionalmente intesi, e forse persone con tempo ed energie maggiori da investire, seriamente, nei loro progetti.
C’è poi, come si diceva, l’altro elemento che induce a pensare che fino a qui sia andato tutto bene: l’amicizia. Ora, i cinque coinquilini sono senz’altro un gruppo affiatato e coeso, in cui tutti si confidano e si aiutano l’un l’altro. Apparentemente. A ben vedere, però, proprio al culmine dell’esaltazione, nei giorni che dovrebbero certificare l’affetto che ha legato i vari protagonisti, questo gruppo implode, come mostrano almeno un paio di scene. Francesca accusa Vincenzo di essere egoista perché, non rifiutando la proposta di lavoro da professore associato in Islanda, vorrebbe implicitamente costringerla a seguirlo «su quell’isoletta del menga», uccidendo così i suoi sogni di gloria; Vincenzo si accorge solo ora che il resto del gruppo si è a lungo divertito, alle sue spalle, in allegre relazioni promiscue che hanno coinvolto anche la sua ragazza (sì, proprio quella per cui lui dovrebbe rinunciare alla carriera accademica); Ilaria continua a non accorgersi dell’interesse che il Cioni nutre per lei, spiattellandogli in faccia le sue prodezze sessuali con riccastri attempati e militari arrapati. Tutti finiscono con l’imputarsi reciprocamente, nell’esplosione di tensioni rimaste silenziate per anni, egoismo e immaturità. Nessuno, infine, tra i cinque superstiti, ha saputo accorgersi della disperazione di uno dei membri del gruppo, dei suoi propositi tremendi di morte.
Tutto ciò significa che, in realtà, l’amicizia tra i protagonisti della storia sia stata soltanto una finzione, un’ipocrisia perpetrata per quieto vivere? No, direi proprio di no. Più semplicemente, anche quell’amicizia è stata coltivata in quella situazione esistenziale effimera, e un po’ illusoria, che è la vita universitaria: com’era un gioco perverso quello rappresentato dal dare esami, contare crediti formativi e pagare tasse, così lo era, per molti aspetti, anche l’organizzare feste selvagge, fare viaggi in macchina rigorosamente tutti insiemi e vagheggiare su quanto «sarebbe bello invecchiare insieme» (ovvero le cose di cui quell’amicizia si è nutrita).
I sentimenti nati durante una convivenza esaltante, non necessariamente resistono alla prova della vita al di fuori delle mura dell’appartamento, al di là dei rituali da universitari: «un giorno anche noi saremo pronti a fotterci a vicenda», osserva, più o meno con queste parole, Vincenzo. E anche qui, emerge di nuovo la silenziosa purezza del Cioni. La scena in cui lui raggiunge Ilaria in terrazza, è dolce e straziante al contempo: laddove lei voleva presentarlo ai suoi genitori come padre putativo fittizio e – come dire? – alquanto transeunte del nascituro, onde evitare di rivelare le sue disavventure sessuali («Io gli dico che c’avevo questo ragazzo tanto bravo, disponibile, poi resto miracolosamente incinta, e lui muore»), il Cioni si propone quale padre adottivo reale («Che si fa, sennò? Ci s’arrende?»).
Da questo punto di vista, Fino a qui tutto bene non può affatto essere considerato un film reticente. Le delusioni e i traumi di cui gli anni universitari sono portatori trovano il loro giusto spazio accanto all’estasi che rende incantata la vita da studenti fuori sede. Manca, nel raccontare questa miscela di gioie e dolori, quel certo cinismo, quella corrosività spietata che rendeva superbe le sceneggiature di Age e Scarpelli. La tradizione della commedia all’italiana sembra esser giunta a Johnson attraverso il filtro di quello che è stato un po’ il mentore del regista pisano, Paolo Virzì: da qui la predilezione per un registro più delicato, per un’accanita ricerca di empatia coi personaggi raccontati. E nonostante questa precisa scelta stilistica (rivendicata, del resto, dallo stesso Johnson), o forse proprio in virtù di tale scelta, Fino a qui tutto bene suggerisce l’idea che molta dell’ebbrezza insita nello status di universitario di oggi sia già, in fondo, un anticipo di disperazione. In quanti, dopo tutto, non ci siamo ubriacati, almeno una volta, brindando coi nostri compagni di corso al futuro di merda che ci aspetta?